L'EDICOLA DI LOU - Stralci e commenti sui telefilm dai media italiani e stranieri
RIVISTA STUDIO
Il ritorno di "Dallas" in una tv cambiata
"Sono stata cresciuta da una madre che chiamava “il villone in stile Dallas” certe
case nuove con troppi portici e steccati bianchi, ma chiamava “Dynasty”
tutti i vestiti che non le piacevano. Non aveva mai guardato un singolo
episodio di nessuno dei due.
La dice lunga sulla nostra memoria, autentica o immaginaria, il fatto
che si possa ancora capitalizzare sul nome di un prodotto di trent’anni
fa, quasi scomparso negli ultimi venti.
Tornato in TV con l’aura dorata del back with more delicious drama, il dramma seriale Dallas è stato ricostruito su una premessa che oggi può suonare curiosa: è una continuazione diretta
del vecchio show, con alcuni attori chiamati a riprendere i loro
personaggi e volti nuovi a interpretare figli, nipoti, ultime mogli.
Messi insieme formano la famiglia Ewing, un clan di texani diventati ricchi con il petrolio (l’ispirazione, secondo i primi sceneggiatori, era Il Gigante).
La storia viene fatta ripartire da due cugini – eredi dei due
protagonisti di un tempo, Bobby e J.R. – che litigano per questioni di
primogenitura sul ranch Southfork: uno ci ha trovato il petrolio,
l’altro cerca fonti di energia alternative; nella contesa vengono
attirati i rispettivi padri, e tutti ricominciano ad azzuffarsi. Continua.
(Parentesi: il nuovo Dallas – Dallas Figlio? – arriverà su Canale 5 in autunno, ma negli Stati Uniti va su TNT,
una rete a pagamento senza una forte identità a parte il trasmettere
fiction a casaccio. Cosa ci ho visto, io, negli anni? The Closer due
volte, le repliche di Law & Order forse.)
Dallas Padre andava in onda la sera, e non credo nessuno si sia mai
illuso sulla quantità di uomini soli che sarebbero stati sedotti dagli
Ewing, ma di certo si poneva come una fonte di intrattenimento per
donne che di giorno lavoravano fuori o dentro casa. L’idea – forse – era
di adattare la formula delle soap operas alla fascia “adulta”, alzando
la posta dei conflitti, investendo più denaro nella produzione, ma
sconvolgendo la regola d’oro delle soap: non deve succedere mai niente. La soap opera è storia orale riferita da chi, lì, non c’era. Il night-time drama,
come Dallas o il suo emulatore Dynasty, è un testo dove accadono cose
grottesche a un ritmo ridicolo e con un’intensità omicida: un supercut di qualcosa che impiegherebbe anni a realizzarsi in tempo reale. Come The Wicker Man in 5 minuti.
Serviva una chiave, però. Un tratto comune a questi eccessi.
La chiave di Dallas era l’eredità.
Mettendo in scena i foschi segreti di gente ricca, offriva la stessa consolazione reazionaria che si prova davanti alle one hit wonder (i soldi non danno la felicità) – molto
significativo che il messaggio sia riproposto oggi senza ritocchi.
Però, col pubblico, cercava anche un legame più profondo. E questo
rimane. Non ci si appassiona a Dallas perché il miliardario ha sposato
la sorella sbagliata, ma perché l’avidità e i debiti sono una cosa che
tutti conoscono, perché tante situazioni patrimoniali erano e sono
riflessi in piccolissimo di quello che succede in Texas, o possono
essere percepite come tali. (Padri che preferiscono un figlio all’altro,
proprietà intoccabili o non divise per anni, occasionale utilizzo della
frase «Zia aveva detto che la spilla la dava a me».) E ancora: i
personaggi agiscono in nome di grane irrisolte che risalgono a due
generazioni prima (verosimile) e da varie pulsioni distruttive,
ma intanto dicono «la famiglia è importante» e «la nonna avrebbe voluto
così». Ostentano un codice d’onore da vecchio gentiluomo del Sud – «qui
si fa tutto con una stretta di mano…» – mentre ordinano furti con
scasso a casa dei parenti intimi. Alla fine è questo che piace, perché
viene sentito come una specie di verità. Lo dimostra il fatto che
trent’anni fa il personaggio concepito come protagonista – Pam, moglie del fratello buono Bobby e avatar ideale dello spettatore – passò in secondo piano, a favore del cattivo carismatico J.R., simbolo vivente di tutta la baracca, antesignano di Montgomery Burns e degno di ricevere la visita del Diavolo nell’ultimo episodio.
(Vi prego, guardate il petroliere faccia a faccia con IL DIAVOLO che lo invita garbatamente a suicidarsi. Questo esiste.)
Dallas è un vero prodotto del pre-Internet, perché è totalmente
destituito di ironia. Non è recitato e montato per consentire un
“secondo livello” a uno spettatore che si considera smaliziato. Va preso
alla lettera. Sarebbe ancora possibile avere un Dallas viewing party, una cena organizzata intorno alla visione della puntata. Ma negli anni ’80 il viewing party non
consisteva nel trovarsi a mangiare/bere e prendere per il culo una
serie TV: la gara di frecciatine che oggi mi sembra passi su Twitter, e
che negli anni ’90 si cristallizzava nella formula tutti a vedere Melrose Place a casa di Stefano tanto poi si va al pub. (Questa frase è una macchina del tempo.) Non a caso, i night-time dramas
degli anni Zero la buttavano subito sull’autoironia, sulla strizzata
d’occhio – il tipico cinismo di chi ti vende una roba brutta
spacciandotela per consapevole, come se il frullatore tramasse ai tuoi
danni – mentre intorno al deridere la TV “troppo melodrammatica” si
costruivano comunità, forum, prodotti di successo. (Il portale Television Without Pity nacque come sito amatoriale “contro” la serie per adolescenti Dawson’s Creek.)
Ieri come oggi, Dallas non contiene alcun secondo livello: Dallas contiene solo se stesso. Dallas vuole bene a Dallas.
A questo punto, cosa si può ottenere dai primi nuovi episodi di un prodotto così antico? A parte una manciata di one-liner
scandite dal Vecchio, che riprende le redini della situazione a colpi
di «i tribunali sono per i deboli di cuore», io ho avuto non una ma due
donne imbroglione truffatrici (la seconda però ha già mostrato segni di
coscienza), la parola “birthright” (diritto di nascita) pronunciata tre
volte, e un depresso catatonico chiuso in ospedale che si riscuote
tutto allegro, pianta una coltellata in faccia al legittimo erede e lo
congeda con «blood is thicker than water… and oil is thicker than both».
(E come la tradurranno questa? Io spingo per “figlio, ecco il sangue
nero della terra”.)
Però.
A mia madre piaceva anche dire “Dallas e Dynasty”, come sinonimo di
“fare una sceneggiata”. Errore frequente, assimilare l’originale e la
copia, però dietro c’erano spinte molto diverse. Dynasty era stato voluto da Aaron Spelling, il patrono della jiggle TV, e la memoria ne trattiene solo alcune tracce: l’esibizione del lusso, le donne che si tirano schiaffoni,
la presenza di una anti-eroina quarantenne, Alexis Carrington Colby, e
il nome più comune per chiamare quel personaggio, “la perfida Alexis”.
(Secondo me era la serie lasciata intravedere in Il raccolto.)
Nonostante il successo di pubblico, Dynasty restò sempre il cugino
zoppo, l’arricchito di guerra. Non sentite parlare di alcun remake,
oggi, mentre sul come rifare Dallas se ne è parlato a lungo, prima di arrivare a questa incarnazione.
Considerando che scrivo da una casa senza ADSL, nella valle emiliana
da cui la mia famiglia è strisciata fuori meno di cent’anni fa dopo
secoli passati esprimendosi a grugniti e occhiacci, in un centro abitato
dove i lupi si avvicinano ogni inverno di più ai giardini sul retro, io
sono lo spettatore ideale di Dallas 2012. Speriamo che piova".
(Violetta Bellocchio, 18.06.2012)













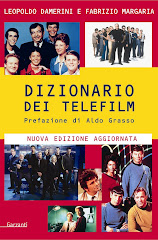.jpg)
















1 commento:
gran pezzo! W DALLAS
Posta un commento