 NEWS - Il genere ospedaliero "made in Italy" è parafiction. Il parere di Aldo Grasso
NEWS - Il genere ospedaliero "made in Italy" è parafiction. Il parere di Aldo GrassoArticolo di Aldo Grasso
Come mai la serialità italiana fatica a rappresentare il dolore e pensare la malattia? Come mai il genere più serializzato della tv americana in Italia gode di cattiva salute? Come mai i medici italiani sono così lontani dalle figure carismatiche del Dottor Kildare o di Marcus Welby, di Donald Westphall di «A cuore aperto» o del Dr House? Una prima risposta, sociologicamente confortante, potrebbe essere questa: le serie americane sono spazialmente lontane, rappresentano un mondo che non ci è familiare; quindi, possono essere vissute come favole. Il dolore continua a rappresentare una fonte perenne di spunti, di narrazioni, di allestimenti, di eroi purché resti distante. Le serie italiane, accusate persino di creare ansia e angoscia, com'è successo a «Crimini bianchi», mettono in scena un mondo con il quale non si può scherzare: ci è troppo contiguo, ne va della nostra salute. Per noi la sanità è quasi sempre sinonimo di malasanità, anche se non è vero. Quando una cosa ci riguarda da vicino, come appunto un luogo che accoglie la sofferenza, stentiamo a credere che si possa fare delle letteratura sulla nostra salute. C'è un'altra risposta, più dolorosa ma più vera. Nella sua modestia espressiva, la fiction italiana non riesce a sublimare la materia di cui parla, non riesce a trasformare una diagnosi in un'indagine sulla malattia, in una continua interrogazione drammaturgica (come in «E.R») o filosofica (come in «Dr House»). Da sempre, la serialità americana ha fatto fare un salto di qualità alla rappresentazione della medicina in tv, molto più dei programmi di divulgazione. Le sue sono lezioni di anatomia televisiva. Spetta infatti alla buona fiction conquistare la malattia con la mente per respingerla come paura. Noi siamo ancora nella difficile fase dell'imitazione, produciamo della parafiction non della fiction.
("Corriere della Sera", 03.11.2008)







.jpg)







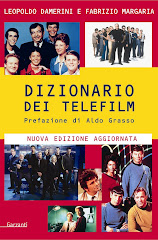.jpg)















Nessun commento:
Posta un commento